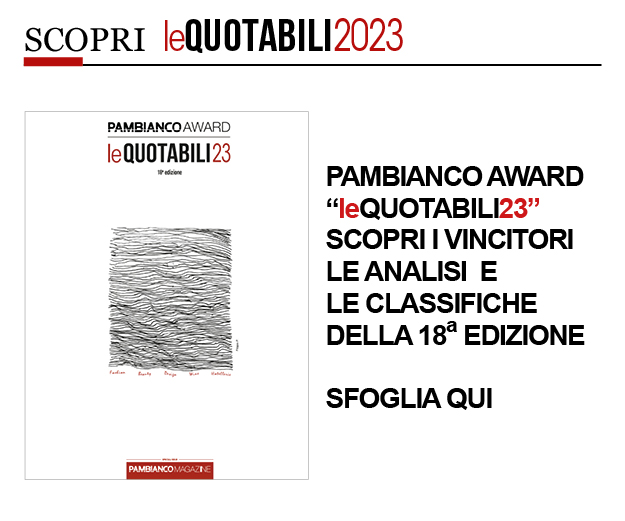Non è un tema nuovo per Metrogramma, studio fondato da Andrea Boschetti e Alberto Francini nel 1999 che si occupa di rigenerazione e criticità urbana da oltre 20 anni. Dalla fortuna iniziale legata a imporanti concorsi vinti a livello nazionale ed europeo, Metrogramma lavora nel 2001 a “4 Città”, piano urbano di Bolzano e ricerca che ha fatto scuola, focalizzandosi sulla densificazione urbana e i suoi diversi scenari. Con un’attenzione sulla persona e sull’idea che l’architettura debba essere un veicolo per migliorare la qualità della vita di chi la abita, Andrea Boschetti dal 2016 è a capo dello studio e collabora con un team multidisciplinare composto da architetti, ingegneri e designer.
Sei stato coordinatore scientifico del PGT (Piano di Governo del Territorio) di Milano dal 2008 al 2011 curandone tutto il processo di progettazione. Qual è l’eredità del lavoro fatto in quegli anni, degli investimenti e delle trasformazioni che hanno cambiato il capoluogo meneghino negli ultimi dieci anni?
La crescita della città deve molto alla nostra strategia di piano, che ha spostato radicalmente l’attenzione del progetto verso lo spazio aperto e pubblico: Milano nei primi anni 2000 ereditava un interesse che andava nella direzione diametralmente opposta rispetto a queste tematiche, la qualità dello spazio pubblico non era un interesse primario. Figlia della grande ingegneria degli anni Ottanta e Novanta, l’unico problema era rendere efficiente la capacità delle strade e delle infrastrutture. Adesso, quell’idea di città è sovvertita. In occasione della Biennale del 2008, insieme a Gianpietro Carlesso presentammo un grande modello in cui era visibile l’equilibrio dinamico urbano in divenire: volevamo rappresentare la città di Milano mostrandone i volumi vuoti per rendere visibile l’equipollenza tra vuoto e pieno. Ciò che ne risultava era una città fatta di vuoti, che potevano assumere un’importanza fondamentale. Ai tempi abbiamo seguito gli accordi presi con gli scali ferroviari cittadini come Scalo Porta Romana e Scalo Farini, quel che doveva accadere con i nuovi progetti per quegli spazi sostanzialmente abbandonati non poteva porsi sulla bilancia solo con due parametri come costi e benefici, ma si doveva estendere il valore del progetto al recupero dei quartieri che insistevano attorno a quegli spazi. E’ definita strategia degli epicentri: dove c’è un’area dismessa, si deve intervenire insistendo sui benefici qualitativi degli spazi verdi. Il piano è nato sotto il cappello di Letizia Moratti e di Masseroli, per poi passare a Pisapia e De Cesaris. Ha subìto delle modifiche, ma anche con Sala e Maran la strategia legata alla qualità del paesaggio è centrale: il progetto Piazze Aperte lo ha dimostrato. La città deve abituarsi alle trasformazioni che non solo sono legate a nuovi grandi edifici, ma si occupano del riuso di spazi già esistenti. Serve prendere le distanze dai grandi progetti autoreferenziali, per spostare il focus su progetti antropocentrici.
Quali sono le potenzialità dell’urbanistica tattica?
Altissime, soprattutto in una città che deve abituarsi alle trasformazioni legate al riuso. Nel 2009 feci un efficace esercizio metaprogettuale per il Regional Plan Association (RPA) con il Politecnico di Torino in collaborazione con le università di Napoli, Cleveland e New York, per provare a trasformare insieme agli studenti l’assetto urbano di Broadway a New York. Quell’esercizio diede vita a un progetto importante, poi attuato dal sindaco Bloomberg rallentando e pedonalizzando Broadway: divenne l’emblema della rigenerazione e della sostenibilità nel mondo. “NYC Boulevard & Broadway, Slow city planning” è stato realizzato mentre lavoravamo al PGT di Milano: quel lavoro è legato all’urbanistica tattica. Gli studenti pensarono fosse un’idea non realizzabile, i commercianti della Broadway erano contro la pedonalizzazione, e quindi decisero di fare delle prove, proponendo un’urbanistica che dava soluzioni diverse, temporanee, senza necessità di diventare permanenti. Oggi invece, dalla temporalità si è passati alla permanenza: quella zona della città è completamente trasformata rispetto ai primi anni 2000. A Milano, con il progetto Piazze Aperte, la sperimentazione è cominciata da Nolo, ma si possono citare Porta Genova, corso Lodi e altri quartieri. Non sono progetti permanenti, ma abituare i cittadini all’idea di riappropriarsi di spazi che erano destinati alle automobili, vuol dire far capire che la città può e deve diventare l’estensione del proprio habitat. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, questi luoghi diventano colossalmente importanti.
Dunque la soluzione è una città che progressivamente diventerà pedonale?
Ovviamente no, ma dobbiamo pensare a una logica di riduzione, nei prossimi anni, dello spazio dedicato all’automobile, per cederlo a piste ciclabili e marciapiedi estesi. Serve riappropriarsi delle piazze, che a Milano sono progettate in modo totalmente sbagliato; non considerano l’ottimizzazione dello spazio coniugata alla fluidità del traffico. Il progetto Milano Future City del 2019, in partnership con Volvo, rispondeva al tema dell’integrazione tra auto e città, dove il settore dell’automotive grazie a servizi digitali e tecnologia implementava la user experience, per un approccio human-centric in città: ci si immaginava un’asse commerciale, quello che da San Babila arriva sino a corso Buenos Aires, che avrebbe potuto riqualificare la metropoli: immaginammo una grande trasformazione, con riduzione delle carreggiate per senso di marcia, ciclabile e marciapiedi allargati, alberature. La pandemia ha accelerato i processi innescati ed è stato possibile portare avanti solo parte del progetto.
Come può il verde urbano e condiviso diventare strumento strategico per i grandi general constructor?
Il cambiamento in atto è strutturale. Quando si riorganizza lo spazio a terra, con la possibilità di inserire anche il verde senza che diventi una ‘marchetta’, ne beneficiano tutti. La riforestazione urbana è l’elemento cardine per lo sviluppo futuro delle città: se guardiamo alla superficie estensiva di Milano ad esempio, oltre il 50% è un spazio potenzialmente progettabile e ora in disuso. I grandi developer hanno finalmente compreso l’importanza dell’attacco a terra, partendo dalla rigenerazione. Siamo passati da una cultura estremamente introversa, in cui il verde era privato, nascosto nei cortili, a progetti virtuosi come quello di Barcellona per le Olimpiadi, oppure le grandi riqualificazioni sulla mobilità in Danimarca. Questi esempi hanno fatto capire che portare attenzione sull’attacco a terra è fondamentale anche per far aquisire il 20 o forse anche 30% di valore in più sull’immobile costruito, quasi come accade per i building brandizzati. Certo, la sostenibilità di una torre residenziale non può essere determinata solamente dall’analisi di dati ingegneristici e dagli aspetti meramente paratecnologici (anzi, questi dovrebbero essere la normalità), se poi gli spazi interni vengono gestiti esattamente nello stesso modo rispetto a qualche anno fa. Il ragionamento a cui siamo abituati è ancora molto legato a un sistema poco proiettivo e di massima efficienza speculativa. Serve fare un ragionamento opposto, e ovviamente serve trovare un developer illuminato. Ad oggi sto lavorando insieme a Stefano Boeri e Petra Blaisse a Genova, su 70 ettari che verranno riqualificati. Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso sorgeranno sotto il ponte progettato da Renzo Piano, e il parco sarà l’epicentro della trasfomazione, luogo cruciale per i cittadini. Attorno sorgeranno edifici, il memoriale delle vittime, uno studentato, edifici per RSA, una nuova stazione, il tutto circondato da questo cerchio rosso metallico, simbolo del progetto. L’amminstrazione ha concordato di dare precedenza alla realizzazione del verde, abbiamo invertito il processo. Io sono sostenitore della “green utopia”: oggi si confrontano due grandi correnti di pensiero, quella del green washing per cui mettendo due alberi in un progetto ti lavi cocienza, e poi quella legata a chi tende a mettere al centro del concept di progetto un vero e sano principio di sostenibilità.
Cos’ha cambiato la pandemia?
Mi trovo in linea con quanto dicono alcuni teorici anglosassoni, penso che non si debba forzare questa reclusione casalinga, altrimenti rischiamo la psicopatia e un’alienazione neofordista. Dobbiamo tornare al lavoro, ma per andarci dobbiamo abituarci a non utilizzare più l’automobile, che in città è inutile. Se nemmeno i mezzi pubblici ci fanno stare tranquilli, allora le città devono trasformarsi, il percorso pedonale da casa a lavoro deve essere gradevole e godibile: se posso camminare andando verso l’ufficio, se lungo la strada incontro bar, servizi, un bel paesaggio, se posso andarci di corsa o in bicicletta, allora lo spazio urbano acquista valore ed è uno spazio di qualità. E’ un modo completamente diverso di guardare alla città rispetto a ciò a cui siamo abituati in Italia, ma penso sia ciò a cui dobbiamo puntare. E il centro non deve essere l’unica area d’interesse per la rigenerazione, che deve coinvolgere ogni quartiere.
Nel Recovery Plan si parla di ripresa economica. Coinvolgere gli architetti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui sono coinvolte digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, dovrebbe essere scontato. Perché non è così?
Ci vorrebbero delle leggi omogenee, a livello nazionale, legate alla qualità dell’architettura e lo sviluppo dei territori. Dovremmo prendere in mano la legge nazionale vera cercando di dare a tutti delle nuove opportunità. Mi pare inconcepibile doverci confrontare con una legge ancora ferma agli anni Sessanta, quando Calvino scriveva “La speculazione edilizia”. In quest’ultimo anno ho tentato, insieme ad altri colleghi architetti che operano su territorio nazionale, di portare all’attenzione della politica e del Presidente Mattarella l’importanza della qualità urbana e dell’architettura. Per ripensare le nostre città, è necessario coinvolgere chi le costruisce, ma a quanto pare questo non avviene. Abbiamo leggi per qualsiasi cosa, ma non per l’architettura. In un Paese come il nostro, con una fragilità di paesaggio simile, trovo assurdo che non ci siano misure di tutela e regolamentazioni. Ma tant’è.
Tornando a Milano, cosa ti auguri per questa città?
Milano deve diventare modello per il mondo. In 10 anni è cambiata del tutto, è diventata la città dove tutti desiderano vivere o lavorare. Penso che i developer debbano diventare più intensivi e meno estensivi in termini di investimenti, è un processo necessario a cui serve però del tempo. Singapore è un bel riferimento, così come Copenhagen e alcune città olandesi. Mi auguro che a Milano si trovi il coraggio di fare un’operazione virtuosa come quella fatta per l’High Line di New York.
di Valentina Dalla Costa