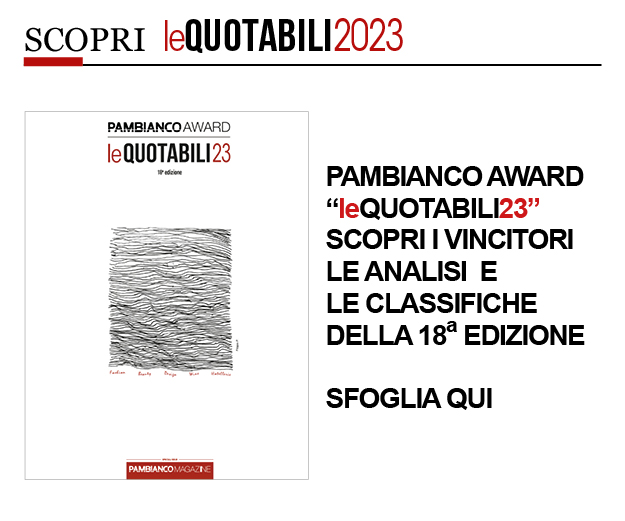Una panoramica internazionale su come si sono evolute negli ultimi 20 anni le strategie all’interno dei musei, una costante flessione dei contributi pubblici hanno spinto la ricerca a fonti alternative.
Oggi, per sopravvivere, i musei devono diventare imprenditori. Parole di Guido Guerzoni, docente Museum Management e membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del Ministero Mibact.
Quali sono e come si sono susseguiti i vari modelli di business nella storia?
In realtà i modelli di business non sono cambiati nel tempo: i musei, come ricorda il disciplinare dell’International Council of Museum, sono “istituzioni permanenti, aperti al pubblico, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compiono ricerche riguardo le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”. In tal senso il business dei musei, nell’accezione di attività prevalente, è sempre rimasto quello educativo, con un’enfasi crescente sul ruolo centrale degli ex visitatori. Semmai, il passaggio epocale occorso negli ultimi vent’anni è stato quello che li ha visti transitare dal modello dei musei “collection centered” ai musei “audience centered”, che pongono il pubblico, inteso in senso ampio, al centro delle proprie strategie. Nel contempo, pressoché ovunque, si è registrata a partire dal 2008 una costante flessione dei contributi pubblici, che ha costretto quasi tutti i musei a cercare fonti alternative e integrative di reddito. Infatti, se si scorrono le serie elaborate da Italian Exhibition Group (IEG, tra i principali operatori europei del settore fieristico e dei congressi, n.d.R.) sul valore del mercato mondiale delle sponsorizzazioni e delle partnership, si ravvisa che è costantemente cresciuto: da 2 miliardi di dollari nel 1984 a 44 nel 2009 (anno in cui, per la prima volta, in alcuni mercati si è registrata una flessione del settore arte e cultura), sino ai 62,7 miliardi di dollari registrati nel 2017, a fronte dei 65,8 del 2018. Cifre imponenti, rispetto alle quali il settore artistico e culturale ottiene su scala planetaria una quota di risorse pari al 7% circa del totale: un dato risultante dall’azione di un combinato disposto che vede mercati declinanti o stabili (Europa e Nord America), a fronte di aree in crescita come BRIC (Brasile-RussiaIndia-Cina), Middle East e l’anello del Pacifico. L’epoca in cui si dava per scontata la crescita dei finanziamenti pubblici e dei contributi privati, del numero di visitatori e della frequenza di visita, è finita, quantomeno in Europa e negli Stati Uniti, dove risiede il 90% degli 80.000 musei oggi esistenti (ne vennero censiti 22.000 nel 1975): oggi per sopravvivere i musei devono diventare imprenditori di sé stessi.
Quali i fattori di cambiamento?
Diversi, ma il più rilevante è rappresentato dallo spostamento dell’asse d’intervento dalla conservazione alla produzione, verso cui i musei sono sempre più orientati. Parlo di produzione di mostre temporanee, produzioni editoriali di diversa natura (dalla messa online dei cataloghi a documentari o coproduzione di film), attività legate all’educational, progetti di engagement. Non è un caso se i musei di successo hanno riconosciuto che senza una costante alimentazione dei propri contenuti, attivata attraverso la rotazione delle collezioni permanenti (che i big, da Tate a Moma, hanno de facto abolito come categoria concettuale), anche i colossi del settore sono destinati a soccombere di fronte a competitor sempre più numerosi e aggressivi. Il mercato dell’attenzione fa gola a tutti, ma per rimanere protagonisti bisogna continuare a produrre, con qualità e mezzi all’altezza delle ambizioni: in ogni parte del mondo i musei producer, i musei publisher sono divenuti parte integrante dei sistemi culturali nazionali e spiccano nelle statistiche comparative tra le strutture più visitate, sebbene abbiano bisogno di risorse crescenti. Questa tendenza ha profondamente modificato le logiche di investimento, con un netto spostamento delle risorse dalle attività tradizionali (conservazione e ricerca) a quelle che sfociano nella “produzione” di nuovi contenuti, significati e interpretazioni, come risposta fornita al radicale mutamento del concetto di cultura occorso negli ultimi dieci anni, con l’abolizione delle gerarchie, la scomparsa dei confini disciplinari, la commistione tra generi espressivi, che hanno profondamente mutato i gusti, le inclinazioni e le aspettative delle ultime generazioni di visitatori, più inclini alla contaminazione e sensibili alle novità, agli eventi temporanei, alle iniziative formative e convegnistiche, alla “produzione di flusso”. In questo contesto non sono più fondamentali i singoli oggetti e la loro collocazione all’interno di sistemi classificatori rigidi, ma l’inserimento in contesti narrativi aperti, che non forniscono una lettura canonica, ma suggeriscono interpretazioni differenti: il visitatore, da destinatario passivo dei verbi disciplinari, è diventato un soggetto attivo, da sedurre e conquistare, lasciandogli una libertà di scelta e, in qualche misura, una parola che non è mai l’ultima. Per questa ragione non viene privilegiato solo il senso della vista; noi scopriamo e interagiamo con tutti i sensi, ragion per cui le istituzioni culturali di nuova generazione, soprattutto quelle prive di capolavori e oggetti eccezionali, producono esperienze, emozioni e sensazioni e forniscono informazioni e conoscenze in formati diversi da quelli precedenti.
Da dove arrivano i ricavi e come sono cambiate le strategie in Italia e all’estero?
All’estero i ricavi, nei casi più virtuosi, arrivano a coprire il 60% dei costi di esercizio, investimenti esclusi, e, con le opportune differenze (in Inghilterra i musei nazionali rimangono ad ingresso gratuito, tanto per fare un esempio), registrano in parti simili introiti da bigliettazione, attività commerciali (spesso gestite da soggetti societari autonomi), fundraising (con piani distinti per membership, privati, corporate, fondazioni/no profit e fondi pubblici locali, nazionali e internazionali) e risorse proprie (diversi musei, soprattutto nordamericani, sono proprietari di endowment di miliardi di dollari). In Italia hanno registrato miglioramenti più che sensibili i musei dotati di autonomia finanziaria dalla riforma Franceschini, ma il nostro rimane un mercato diverso dagli altri, con larghe sacche di arretratezza, soprattutto manageriale e in cui alcune comparazioni sono prive di senso: rammento sempre che gli Uffizi, il museo italiano più visitato, ha una superficie espositiva di soli 12.000 metri quadrati, a fronte dei 180.000 del Louvre. Se paragonassimo i musei in funzione del numero di visitatori per metro quadrato saremmo stabilmente nella top ten mondiale e se liberalizzassimo l’accesso abolendo il numero chiuso occuperemmo sicuramente i primi tre posti (salvo trovarci distrutti i musei nel giro di pochi anni).
I casi più significativi ed emblematici: quali sono e per quale motivo potrebbero essere un modello da prendere come esempio?
Di casi ce ne sono diversi: il Louvre ha triplicato le superfici e i visitatori in trent’anni, dopo aver investito nell’operazione “Grand Louvre” più di un miliardo di euro (non lontano dal 1,2 della Museuminsel di Berlino); Tate Modern, secondo l’analisi d’impatto della London School of Economics, nei primi cinque anni di vita ha creato tra 2000 e 4000 nuovi posti di lavoro, il Guggenheim di Bilbao tra l’ottobre 1997 e gennaio 2000 ha fatto crescere il PIL dell’area dello 0,47% creando 3816 posti di lavoro e facendo aumentare del 54% i flussi turistici dei Paesi Baschi; l’Hermitage, percorso palmo a palmo, richiede ai visitatori più pignoli una sgambata di 31 chilometri, mentre lo Smithsonian Institution di Washington ha superato i 6000 dipendenti. In Cina nel 1978 c’erano 349 musei: nel luglio 2019 erano diventati 5100, con un miliardo di visitatori registrati nel 2018 e l’obiettivo di arrivare a 6100 entro la fine del 2020. Nel mentre si sono moltiplicati i franchised museum che perseguono economie di scala e di dimensione a livello planetario (Tate, Pompidou, Paley Center, Reina Sofia, Guggenheim, Imperial War o Ludwig), si sono sperimentate forme di merger and acquisition (come il Moma-PS1) e accordi di coproduzione/codistribuzione (Hermitage), sono state varate travelling exhibitions pluriennali (Barnes Foundation ha fatto scuola) e firmati accordi strategici da 1,4 miliardi di euro (Louvre di Abu Dhabi), programmando i calendari espositivi su orizzonti decennali. Insomma, nessuno è stato fermo a guardare, nel segno della globalizzazione più feroce e della chiara gerarchizzazione tra pochi pesi massimi e migliaia di pesi piuma.
Ci sono dei musei che, per far fronte a una crisi, hanno completamente rivoluzionato la loro impostazione e si sono risollevati grazie a questo cambiamento?
In generale no, non ci sono ricette miracolose. Un conto è trasformare un museo di piccole dimensioni, un altro rivoluzionare un pachiderma. Ma i musei sono istituzioni secolari, con collezioni millenarie, in cui funzionano i cambiamenti graduali, con manager e staff all’altezza dei compiti. In questo i musei non sono diversi da molte aziende: la grande differenza la fanno le persone e, nel caso di specie, i committenti: per esperienza personale ho visto musei strepitosi finire miseramente per l’ignoranza e l’inadeguatezza dei loro organi di governo. Un buon museo ha bisogno di avere committenti e gestori all’altezza. Semmai, quello che va ricordato, è che il 90% dei grandi musei internazionali ha investito e sta investendo cifre colossali per rinnovare i propri spazi e ospitare nuove funzioni, a tutti i livelli: basti pensare ai nuovi depositi del Louvre a Lieven o alla nuova sede del Victoria & Albert East London.
Qual è la situazione in Italia?
Il nostro è un Paese rimasto assorto in una bolla ventennale, lontano dai grandi dibattiti e dai principali cambiamenti internazionali, in cui la presenza nel campo della contemporaneità è stata garantita soprattutto da strutture private – da Hangar Pirelli alla Fondazione Prada – e da musei corporate (penso al caso straordinario delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo). Pur avendo musei storici di straordinario valore, ci troviamo alla periferia estrema dei dibattiti più affascinanti e delle pratiche più innovative, con due generazioni di talentuosi giovani museologi ancora fuori dal mercato del lavoro.
Il progetto architettonico che si integra con la città e il design degli spazi interni ‘aiutano’?
Il rapporto tra musei, città e progettazione architettonica è sempre stato articolato, ma negli ultimi anni ha raggiunto un livello di complicità e/o conflittualità mai visti in precedenza. Paradossalmente il recente successo planetario del museo come archetipo architettonico è alle radici della sua eterogenesi dei fini, che si è tradotta in uno spossessamento dei tradizionali ruoli progettuali e nella richiesta, esplicita o implicita, di svolgere ruoli differenti da quelli assegnati in passato: attrattori turistici, landmark urbani, totem iconici, simboli di civic reconquista, cattedrali laiche, public condenser, audience magnets, cities regenerators, economic resurrectors e flagship projects. In un crescendo di metafore trionfalistiche, che, parafrasando il titolo di un brillante saggio di Hans Belting, hanno irreversibilmente trasformato i musei da places of reflection a places of sensation.
Come il mondo digital interviene sui cambiamenti?
In modo talvolta marginale, talvolta rilevante, a seconda dell’intelligenza degli osservatori e dei protagonisti dei processi di cambiamento. Ma come in tutte le esperienze live, è la realtà a fare la differenza. Sono “le cose” fisiche a emozionare e i musei li custodiscono amorevolmente da sempre. Tuttavia i processi di digitalizzazione non hanno solo ampliato la gamma dei temi trattabili in sede museale, ma hanno rivoluzionato anche le modalità di progettare, gestire e fruire i musei stessi; se gli studi sulle visitor experiences tradizionali evidenziano che i visitatori sostano all’interno di un percorso museale per un arco di tempo compreso tra l’ora e le due ore – con una costante caduta delle soglie di attenzione – le ricerche sulla fruizione di alcuni contenuti digitali dimostrano che suscitano interesse per un periodo di tempo inferiore ai cinque minuti. La vera sfida, a questo punto, è trovare lo spazio all’interno dei musei per esperienze digitali più lunghe e dalla fruizione più lenta, dedicate a pubblici non solo frettolosi e superficiali. Non è un caso Sir Nicholas Serota, l’ex direttore della Tate Gallery già dieci anni fa aveva vaticinato che: “il futuro dei musei rimarrà radicato negli edifici che occupano, ma dovrà essere indirizzato a un pubblico globale: i musei dovranno essere presenti nei luoghi in cui le persone di tutto il mondo si incontreranno per conversare. Le istituzioni che cresceranno con questi obiettivi più velocemente e validamente saranno quelle che in futuro godranno
della maggiore autorevolezza”. In tal senso, ciò che la cultura digitale può offrire ai musei non è solo la gestione più o meno interattiva degli spazi e delle collezioni, ma la possibilità di raggiungere una popolazione sempre più ampia di visitatori e di fruitori di contenuti, che non sono limitati ai visitatori fisici, ma si estendono a comunità che raccolgono e scambiano informazioni in rete sulle medesime tematiche. Grazie al digitale i musei si estroflettono e fuoriescono dai tradizionali vincoli spazio-volumetrici: diventano editori e produttori di contenuti di grande qualità e autorevolezza.
di Valentina Dalla Costa